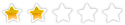Interpreti R. Dean Smith, I. Theorin, M. Breedt, J. Rasilainen, R. Holl
direttore Peter Schneider
orchestra festival di Bayreuth
regia Christoph Marthaler
regia video Michael Beyer
formato 16:9
sottotitoli Ing., Fr., Ted., Sp.
3dvd Opus Arte 1033
Regista vero, Marthaler senza dubbio lo è. È svizzero di nascita, ma tedeschissimo come uomo di teatro, quindi racconta poco o punto preferendo svolgere piuttosto una tesi: e per farlo, pare abbia assoluto bisogno del miserabilismo quotidiano cui impronta tutti i suoi spettacoli. Nel 2005, Wolfgang Wagner affidò a lui il Tristan destinato a prendere il posto di quello, meraviglioso, di Heiner Müller fortunatamente pubblicato dalla Dg. Ideale dunque, il presente video, per toccar con mano la differenza che intercorre, analoghi essendo nudità scenica ed economia gestuale estrema, tra chi – come Marthaler – proponga astratti teoremi, e chi – come Müller – un pensiero non importa quanto cerebrale lo sa invece sciogliere in articolata teatralità.
Che il primo atto svolga un grandioso tema dell’attesa, è indubbio. Discutibile che ciò debba tradursi in un salone spoglio anni Cinquanta, singolarmente sgradevole causa anche la fredda luce che proviene da due file di quadrati sul soffitto, fatti accendere e spegnere tutti insieme e tutto d’un colpo a riflettere – si suppone – i diversi stati d’animo. Divani color giallo sporco (quello che mia nonna, molto amante delle immagini pratiche, chiamava “color can che scappa”) sono addossati alle pareti fatte di grandi listoni di legno: e davanti, sopra al parquet spinato, sono sparpagliate quattro poltrone più un’infinità di sedie. Isolde in elegante abito lungo di lana azzurra, Tristan in blazer pure blu e cravatta regimental, Kurwenal in tilt. Le sedie servono a definire l’isteria di Isolde, che le rovescia metodicamente una dopo l’altra durante il racconto: per il resto, immobilità pressoché assoluta. Evidente l’aggancio sia a Beckett sia a molto teatro della seconda metà del secolo scorso, diretto a scardinare la convenzionalità tanto del linguaggio quanto della sua messa in scena. Quel tipo di teatro, cioè, rubricato sotto il generico termine “postmoderno”: da Peter Handke a Elfriede Jelinek, da Thomas Bernhard a Botho Strauss, fino al mondo claustrofobico di Werner Schwab. Ma se evidenti sono i rimandi scenico-gestuali, resta invece apertissimo il quesito se, e nel caso in che misura, essi possano entrare in sintonia con la musica in generale e con quella wagneriana in particolare.
Non sono cioè convinto che al second’atto Tristan e Isolde debbano stare seduti immobili senza guardarsi per decine di minuti in una stanza del tutto vuota (con le pareti tappezzate dello stesso giallo dei divani precedenti, su cui sono visibili quattordici interruttori bianchi che Isolde aveva premuto di continuo parlando con Brangäne, a simboleggiare l’alternanza giorno-notte), con al centro due panchette imbottite accostate, di color giallo e dunque ton sur ton col tailleur giallo canarino di lei: unico gesto essendo lo scivolare a terra di Tristan che pone il capo in grembo a Isolde mentre la mano allunga il lungo guanto bianco che lei s’era sfilato e ora stringe tra i denti. Il gesto magari rimanda, nella suggestionabile fantasia del cinefilo, all’immortale Gilda di Rita Hayworth: ma la sensualità debordante dell’eventuale modello qui scade semmai a una Doris Day. E meglio sarebbe stato restare sull’immobilità, piuttosto che vedere, durante la tirata di Marke, Kurwenal dar segni di squilibrio mentale picchiando ripetutamente il capo sulle pareti.
Ancor meno convince il terz’atto. Col letto da ospedale su cui giace Tristan posto su una stretta pedana rialzata e circondata da un parapetto metallico, sorta di reperto principale d’un ipotetico Museo del Tardormanticismo-quasi-Decadente. Con tutti i personaggi, Pastore e Pilota compresi, che allorché smettono di cantare (non muore beninteso nessuno, né alcuno combatte) vanno a poggiare la fronte sulle pareti, e lì stanno. Con Tristan che muore sul pavimento e Isolde che sale invece sul suddetto letto, canta e si tira il lenzuolo sopra la testa. Teatro postmoderno? Senz’altro. A me questo teatro piace poco nei suoi testi, e punto nel suo stile scenico: che mi pare una sorta di passepartout buono per qualunque drammaturgia. Nel caso, però, preferisco di gran lunga gente come Neuenfels o Konwitschny, che propongono regie discutibili fin che si vuole; che a quella dell’autore sovrappongono spesso una propria e magari opinabile drammaturgia: ma che sono comunque regie fatte di gesti, relazioni tra personaggi, conflitti che nello spaccare e ricomporre l’arco narrativo ne definiscono le psicologie. Che, in una parola, fanno teatro anziché discutere una tesi di dottorato di ricerca. Dottorato, peraltro, cui fa riscontro un ben modesto liceo di provincia per quanto attiene alla parte musicale.
Schneider, veramente, più che al liceo fa pensare alla ragioneria: pulitino e perfettino, ogni nota confezionata come va, della serie ci sono ma non mi si nota. Lo spettacolo nacque con Nina Stemme, figuriamoci, troppo grande artista per restare a lungo nella Bayreuth di Wolfgang: Irene Theorin è brava, ma non abbastanza brava da evitare un acuto rimpianto si sia aspettato un anno di troppo per realizzare il video. Robin Dean Smith ha facilità in alto, ma nient’altro. Michelle Breedt è opaca e stridula; Robert Holl un Marke di linea gessosa, senza acuti e senza gravi, impalato e singolarmente antipatico; Jukka Rasilainen un Kurwenal ascoltabile.
Elvio Giudici