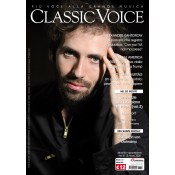La “prima” del Nome della rosa al Teatro alla Scala racconta una volta di più le divergenze tra spettatori ed esperti in rapporto alla musica contemporanea. Non entusiasti i secondi (qualche compositore era infiammato come in antiche querelle operistiche), molto coinvolti i primi, che hanno premiato la proposta di Francesco Filidei non solo con il tutto esaurito ma con una speciale attenzione e coinvolgimento: quasi nessuno ha lasciato la sala dopo la prima ora e mezza “filata”, tributando applausi convinti ed entusiasti dopo tre ore di ascolto. Un trionfo, in effetti, per il cinquantaduenne compositore pisano. Chi ha ragione? Forse tutti e due. Il fatto è che Filidei ha dato l’impressione di comportarsi come quei pittori che prima di finire un quadro si allontanano per vedere l’effetto che l’opera fa a chi la guarderà, per aggiustare il tiro di pennello. È un processo, in realtà, che Filidei compie da molti anni. E che consiste nel trasferire la sua “lingua” – che non fa sconti e concessioni eclettiche e non indulge a piacionismi e ruffianerie, ma resta orgogliosamente “contemporanea” – in un contesto narrativo lineare, comprensibile, e perfino thrilling come quello del libro più venduto di Eco (e forse della recente letteratura italiana). Senza vergognarsene. Rovesciando una sua dichiarazione, è come se ci trovassimo in un’esposizione di quadri d’avanguardia installata in un’antica e rassicurante dimora, o in una fantasiosa Wunderkammer.
La “prima” del Nome della rosa al Teatro alla Scala racconta una volta di più le divergenze tra spettatori ed esperti in rapporto alla musica contemporanea. Non entusiasti i secondi (qualche compositore era infiammato come in antiche querelle operistiche), molto coinvolti i primi, che hanno premiato la proposta di Francesco Filidei non solo con il tutto esaurito ma con una speciale attenzione e coinvolgimento: quasi nessuno ha lasciato la sala dopo la prima ora e mezza “filata”, tributando applausi convinti ed entusiasti dopo tre ore di ascolto. Un trionfo, in effetti, per il cinquantaduenne compositore pisano. Chi ha ragione? Forse tutti e due. Il fatto è che Filidei ha dato l’impressione di comportarsi come quei pittori che prima di finire un quadro si allontanano per vedere l’effetto che l’opera fa a chi la guarderà, per aggiustare il tiro di pennello. È un processo, in realtà, che Filidei compie da molti anni. E che consiste nel trasferire la sua “lingua” – che non fa sconti e concessioni eclettiche e non indulge a piacionismi e ruffianerie, ma resta orgogliosamente “contemporanea” – in un contesto narrativo lineare, comprensibile, e perfino thrilling come quello del libro più venduto di Eco (e forse della recente letteratura italiana). Senza vergognarsene. Rovesciando una sua dichiarazione, è come se ci trovassimo in un’esposizione di quadri d’avanguardia installata in un’antica e rassicurante dimora, o in una fantasiosa Wunderkammer.
 Tutto quello che conosciamo del libro (e del film) è presente: l’ambientazione medievale, i personaggi, la serie di omicidi, le scene e i caratteri grotteschi (il mitico Salvatore, qui interpretato da Roberto Frontali), le disquisizioni filosofiche accese dall’Inquisitore (la voce contraltile di Daniela Barcellona), l’incendio finale, il racconto di Adso da vecchio che ripercorre le vicende. E questa, certo, è un’assicurazione di comprensibilità. Talvolta questa “fedeltà” è perfino eccessiva: il ricordo dell’anziano Adso – che qui è affidato al coro, ben preparato da Alberto Malazzi, immobile sulla parte alta del palcoscenico come in una cantoria – poteva essere utilizzato per sfoltire e riassumere qualche dialogo di troppo, dove il parlato abbonda a scapito dei momenti emozionali che pure non mancano: tra tutti il duetto alla fine del I atto tra Adso e la Ragazza, una vera espansione lirica che arriva come una boccata d’ossigeno.
Tutto quello che conosciamo del libro (e del film) è presente: l’ambientazione medievale, i personaggi, la serie di omicidi, le scene e i caratteri grotteschi (il mitico Salvatore, qui interpretato da Roberto Frontali), le disquisizioni filosofiche accese dall’Inquisitore (la voce contraltile di Daniela Barcellona), l’incendio finale, il racconto di Adso da vecchio che ripercorre le vicende. E questa, certo, è un’assicurazione di comprensibilità. Talvolta questa “fedeltà” è perfino eccessiva: il ricordo dell’anziano Adso – che qui è affidato al coro, ben preparato da Alberto Malazzi, immobile sulla parte alta del palcoscenico come in una cantoria – poteva essere utilizzato per sfoltire e riassumere qualche dialogo di troppo, dove il parlato abbonda a scapito dei momenti emozionali che pure non mancano: tra tutti il duetto alla fine del I atto tra Adso e la Ragazza, una vera espansione lirica che arriva come una boccata d’ossigeno.
Per il resto Filidei scrive una partitura ricchissima e molto “sua”: l’invenzione sonora, originalissima, è sempre legata al gesto che l’ha prodotta, al materiale, allo strumento e alle sue modalità di emissione. È un linguaggio camaleontico, capace di parlare, evocare, citare, spiegare: se la trama innerva la musica, quest’ultima illustra e dà ritmo alla parola come negli antichi “madrigalismi”. Ci sono dunque allusioni al gregoriano e all’antica polifonia medievale (dall’organum su note lunghe tenute alla scrittura “nota contro nota”), al canto barocco e alle espansioni “orchestrali” ottocentesche, verdiane, mahleriane e pucciniane, talvolta divertite citazioni letterali; ma predomina il suono della “nuova musica”: gli ingranaggi ritmici sfavillanti, gli ostinati post-minimalisti, i pedali sonori “cosmici” solcati da lampi di luce, le dissoluzioni pulviscolari, i giochi ornitologici alla Messiaen (tipo lo squeaky toy, paperotta di plastica) e un ampio parco percussivo, negli omicidi ridondante: un Medioevo “barocco” restituito con tempi più comodi del previsto dal capitano Ingo Metzmahcer sul podio di una disciplinata orchestra scaligera. E se per “tenere desta l’attenzione” Filidei cambia scrittura molto frequentemente, anche all’interno della singola scena, il rischio della frammentazione c’è. Le voci, quando non costituiscono affascinanti e virtuosistici tableaux di solisti, coro in scena e “fuori scena”, vero punto di forza della scrittura vocale, sono perlopiù parlate (con qualche goffaggine nell’italiano di Kate Lindey, Adson, e di Lucas Meachem, Guglielmo), oppure declamano ricalcando i motivi ritmici d’orchestra. Quello di Filidei è un teatro di invenzioni ritmico-sonore più che di canto.
 La drammaturgia, prescindendo dalla complessa costruzione simmetrica che converge, simile alla Rosa, sul “duetto d’amore” (e che riguarda anche la costruzione musicale profonda), è labirintica. Come in Eco – ricorda il drammaturgo Mattia Palma – si disperde in svariate piste, trovando quella giusta quando ormai l’abbazia brucia per mano dell’oscurantista Jorge Da Burgos (Gianluca Buratto, indisposto alla prima). Lo spettacolo di Damiano Michieletto ne dà riscontro lineare, alludendo con un sistema di veli disposto da Paolo Fantin alla torre ottagonale che contiene la biblioteca e disponendo i personaggi come “marginalia” dei codici miniati sulla pagina nera del palcoscenico (coloratissimi per contrasto i costumi di Carla Teti), con una serie di pertinenti e poetiche soluzioni (una fra tutte Adso in braccio alla Madonna che associa alla vagheggiata Ragazza, affidate entrambe alla vocalità aerea di Katrina Galka). Alla fine la biblioteca crolla, i veli si afflosciano come gli antichi manoscritti dissolti da fuoco. Ma un vero protagonista c’è, ed è il libro che nessuno doveva leggere (il secondo libro della Poetica di Aristotele dedicato al riso e alla commedia), che uccide passando di mano in mano come un Ring e che va salvato per il futuro dell’umanità. Dargli maggiore presenza e centralità potrebbe essere un’idea per un prossimo, auspicabile – anche se non facile per impegno e dimensioni – allestimento dell’opera.
La drammaturgia, prescindendo dalla complessa costruzione simmetrica che converge, simile alla Rosa, sul “duetto d’amore” (e che riguarda anche la costruzione musicale profonda), è labirintica. Come in Eco – ricorda il drammaturgo Mattia Palma – si disperde in svariate piste, trovando quella giusta quando ormai l’abbazia brucia per mano dell’oscurantista Jorge Da Burgos (Gianluca Buratto, indisposto alla prima). Lo spettacolo di Damiano Michieletto ne dà riscontro lineare, alludendo con un sistema di veli disposto da Paolo Fantin alla torre ottagonale che contiene la biblioteca e disponendo i personaggi come “marginalia” dei codici miniati sulla pagina nera del palcoscenico (coloratissimi per contrasto i costumi di Carla Teti), con una serie di pertinenti e poetiche soluzioni (una fra tutte Adso in braccio alla Madonna che associa alla vagheggiata Ragazza, affidate entrambe alla vocalità aerea di Katrina Galka). Alla fine la biblioteca crolla, i veli si afflosciano come gli antichi manoscritti dissolti da fuoco. Ma un vero protagonista c’è, ed è il libro che nessuno doveva leggere (il secondo libro della Poetica di Aristotele dedicato al riso e alla commedia), che uccide passando di mano in mano come un Ring e che va salvato per il futuro dell’umanità. Dargli maggiore presenza e centralità potrebbe essere un’idea per un prossimo, auspicabile – anche se non facile per impegno e dimensioni – allestimento dell’opera.
Andrea Estero
MILANO
Filidei
Il Nome della rosa
direttore Ingo Metzmacher
regia Damiano Michieletto
teatro alla Scala
***/****
Su “Classic Voice” di carta, o nella replica in digitale, c’è molto di più. Scroprilo tutti i mesi in edicola o su www.classicvoice.com/riviste.html