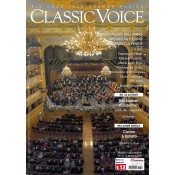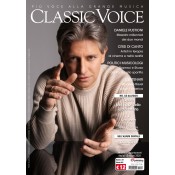soprano Eleonora Buratto direttore Sesto Quatrini orchestra Carlo Felice di Genova cd Pentatone 5187409

Impasto timbrico molto bello. Tecnica da vecchia scuola nell’appoggiare, controllare e proiettare il fiato al fine di garantire, alla considerevole ampiezza della linea, omogeneità (nessun “gradino” e men che mai vibrato), morbidezza (gravi bruniti e ricchi d’armonici, settore acuto limpido e squillante), duttilità dinamica (sfuma e rinforza nel giro d’un soffio), legato impeccabile anche nelle frasi di più lunga gettata, governato da musicalità assoluta. Questo il materiale – posseduto e sempre più affinato – che fa di Eleonora Buratto una grande cantante. Ma il come impiega questo pur indispensabile substrato tecnico, fa di lei molto di più: una grandissima artista, che s’esprime al meglio grazie al superbo accompagnamento di Sesto Quatrini, alla testa dell’orchestra genovese in gran forma.
Imogene, Bolena, Lucrezia Borgia (tutte e tre con l’intero finale d’opera), la Contarini dei Foscari, Mina dell’Aroldo: personaggi accomunati dall’impervia difficoltà delle rispettive scritture, tutte peraltro sovranamente risolte in sede esecutiva, ma assai diversi tra loro. Diversità sottolineata benissimo dal gioco degli accenti, dei colori, dei chiaroscuri. Il vaneggiare lancinante di Imogene; quello molto più chiaroscurato di Anna (fascinosa, la progressione che dal sognante “Al dolce guidami”, tutto sospeso sul soffio d’una sostenutissima mezza voce, arriva al veemente saettare di “Coppia iniqua” dando pieno valore alla sagacia di Donizetti che prevede il ponte teatrale di “Cielo, ai miei lunghi spasimi”); la spasmodica intensità drammatica della madre Lucrezia, che si scarica nella vertigine cabalettistica d’un “Era desso il figlio mio” che fa della Buratto non soltanto una delle migliori vocaliste del nostro tempo bensì – e per me conta assai di più – una delle sue più compiute interpreti. Cosa che ancor più perentoriamente vale per i due brani verdiani, che come ben sappiamo sono tra i più impervi – espressivamente non meno che vocalmente – mai usciti dal Verdi uomo di teatro: scolpitura di dizione al servizio d’un gioco accentale vario ma sempre appropriato perché sempre fatto scaturire dall’interno della frase (mai scaraventato sopra per l’effetto facile; sentire, nella gran scena di Lucrezia, quel “s’aggiunge lo scherno” del tutto privo d’ogni gutturale, retoricissima risonanza di petto e intriso invece di ben più rovente amarezza), cui si dona quindi quel valore teatrale che dell’intero mondo verdiano è la vera, inimitabile – ma difficile, oh quanto – stella polare.
Elvio Giudici