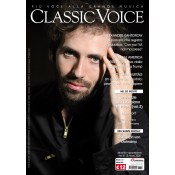interpreti V. Goikoetxea, P. Pretti, A. Markov, M. Torcaso, G. Sagona direttore Daniele Gatti orchestra Maggio Musicale Fiorentino regia Massimo Popolizio dvd Dynamic 38057

La doppietta pucciniana di Gatti allo scorso Maggio (Tosca e Butterfly) è destinata senza dubbio a porsi come punto di riferimento obbligato della storia interpretativa pucciniana. Opere entrambe straeseguite e vittime costanti del puccinismo, riascoltarle quali “di Puccini” è un balsamo. Asciutta, essenzialissima, financo scabra proprio là dove il puccinismo più spampana (sentire solo il Te Deum reso una sorta di mostruosa, terrificante marcia funebre, a mostrare come forse mai prima la collusione parimenti oppressiva Chiesa-Stato; i lividi, gelidi colori che si stendono all’apertura del second’atto; all’apertura del terzo, lo sfinimento per niente languido e baroccheggiante – come pur sublimemente lo faceva Karajan – bensì intriso di melanconia via via sempre più tragica nel lividore dei fiati posti in sensazionale evidenza), questa Tosca è un vero e proprio inno al teatro.
Teatro espressionista, in nessun momento partecipe del cosiddetto verismo della Giovane Scuola: i tempi larghi – che la magnifica orchestra regge sovranamente – non rilasciano ma al contrario intensificano come implacabili giri di vite la tensione narrativa, l’incessante oscillazione agogica della quale fa galleggiare sul suo flusso ininterrotto formidabili particolari strumentali (l’arpa, persino: chi mai l’ha sentita così nitida e ghiacciata?) ma senza mai perdere l’aggancio col canto, che ovunque è vero canto, lasciando al puccinismo i parlati e i cachinni di bieca intenzione e ridicola realtà. La sintonia tra quanto si sente e si vede è assoluta. Come già nel 1986, al vecchio Comunale con Jonathan Miller, la Roma è quella piacentiniana dell’Eur, imponente e gelida nei suoi marmi marezzati (con un tocco da scienza pazza fornito da feti immersi in vasi di formalina, sparsi nella stanza di Scarpia) entro cui la gestualità imposta da Massimo Popolizio riecheggia i moduli del suo mentore Ronconi – troppo, per me che non ho mai saputo amarlo – oscillando tra naturalezza splendida e ricca di particolari azzeccatissimi (memorabile il ragazzino che intona lo stornello giocando con la fionda e scambiando coi compagni le figurine, m’immagino quelle per cui l’Italia anni Trenta impazziva, le Buitoni-Perugina col loro introvabile feroce Saladino; e vivaddio riuscitissimo l’ammazzamento di Scarpia, che muore tutto raggomitolato con la carotide tagliata e lei col piede lo rivolta e poi sì, gli pone i due rituali candelabri a lato – però glieli pone da grande attrice -, ma il crocifisso è quello che porta al collo e glielo getta sopra con una smorfia di supremo disgusto), contrapposta a repentine “citazioni” cultural-chic da cinema dei telefoni bianchi, con relativo mulinar di braccia e gran sdraiarsi e rotolarsi sul pavimento: a prescindere da tali superflui cincischi, recitano comunque tutti benissimo.
Vanessa Goikoetxea era pressoché ignota da noi, e ora è da considerare Tosca tra le maggiori che un teatro possa oggi sperare: carisma scenico a pacchi, gran padronanza tecnica, onde tutto un chiaroscuro il suo calibratissimo gioco d’accenti, che fa completo aggio d’un timbro non baciato dagli Dei del canto ma invece dal Dio del teatro, tanto si rivela essere personale: e come Gatti e lei portano a casa il “Vissi d’arte”, non lo si scorderà mai più. Un leggero bemolle glielo infligge la ripresa video di Matteo Ricchetti: di per sé eccellente, ma che evidenzia il suo non scollar mai gli occhi dal direttore, sminuendo così, in video in luogo del teatro dal vivo, l’immediatezza di molti momenti. Alexey Markov è un grande Scarpia, giocato tutto sull’eleganza del gesto e l’asciuttezza gelida dell’accento, senza il minimo ricorso al birignao. Piero Pretti è come sempre un maestro di canto morbido e tutto sul fiato, con perentori squilli argentini e mezzevoci splendide. Un Angelotti un po’ pallido (e anche lui preoccupatissimo di non staccar gli occhi dalla bacchetta) ma cantato bene da Gabriele Sagona, e bravissimo il Sagrestano di Matteo Torcaso, irresistibile nella scocciatissima noia con cui snocciola l’Angelus rendendolo una tiritera sonnacchiosa.
Elvio Giudici