Editore Garzanti Pagine 216 Euro 16
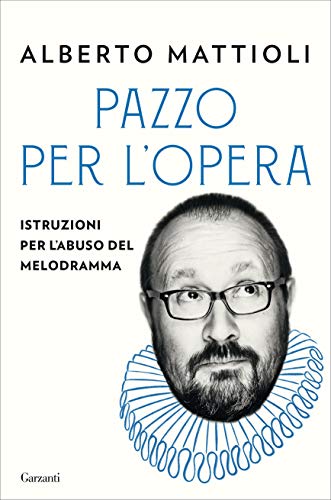 Un po’ mi vien da ridere, all’idea di scrivere due note circa l’ultimo libro di Alberto, sorta di Mattioli2 (sottotitolo: non “la vendetta” bensì “confermo e ribadisco”) dopo il precedente Anche stasera, quando era arrivato a 1000 serate d’opera in presenza, e adesso ne ha aggiunte 800 (perché è sempre un giovincello, visto da me che ho quasi trent’anni più di lui e che quando entrai alla Scala ero vispo, sì, ma ancora nella preadolescenza). Mi vien da ridere perché mi sembra di parlare di me stesso. Capita difatti il raro caso di essere praticamente sempre in totale sintonia critica con lui (meno in quella cronachistica, che lo vede occuparsi di fenomeni da baraccone tipo l’ultima Gruberova, e pensa che la baracconata sia componente ineliminabile del teatro d’opera e dunque l’esalta, laddove io la subisco però ogni volta esecrandola; ma è perché lui è giornalista, e pure eccellente, mentre io giornalista non sono): sicché non avrei gran che da commentare. Allora spostiamo “il dibbattito”.
Un po’ mi vien da ridere, all’idea di scrivere due note circa l’ultimo libro di Alberto, sorta di Mattioli2 (sottotitolo: non “la vendetta” bensì “confermo e ribadisco”) dopo il precedente Anche stasera, quando era arrivato a 1000 serate d’opera in presenza, e adesso ne ha aggiunte 800 (perché è sempre un giovincello, visto da me che ho quasi trent’anni più di lui e che quando entrai alla Scala ero vispo, sì, ma ancora nella preadolescenza). Mi vien da ridere perché mi sembra di parlare di me stesso. Capita difatti il raro caso di essere praticamente sempre in totale sintonia critica con lui (meno in quella cronachistica, che lo vede occuparsi di fenomeni da baraccone tipo l’ultima Gruberova, e pensa che la baracconata sia componente ineliminabile del teatro d’opera e dunque l’esalta, laddove io la subisco però ogni volta esecrandola; ma è perché lui è giornalista, e pure eccellente, mentre io giornalista non sono): sicché non avrei gran che da commentare. Allora spostiamo “il dibbattito”.
Quando si pubblica un libro, per prima cosa occorre porsi la questione del target: a chi si rivolge, chi può/deve leggerlo? In questo caso, la risposta è allo stesso tempo complessa e facilissima. Perché leggerlo possono tutti in quanto ogni riga ha lo stile inconfondibile che di Alberto ben conosciamo: in aggiunta all’essere scritto in italiano (cosa rara, oh quanto!), è brillante, di quelli che scorrono ch’è un piacere ma che scorrendo ti ficcano dentro un’infinità di stimoli acuminati. Dunque, lettura per tutti: suddivisa, a mo’ di locandina teatrale, in cinque atti (regia, tecnica vocale, quattro ritratti d’artista, titoli troppo o troppo poco rappresentati, la crisi dell’opera) e quattro intervalli (il variegato sottobosco dell’opera, che purtroppo c’è ma che a mio parere proprio la divertente descrizione finisce col giustificare, e secondo me non è più tempo di farlo perché così lo si accetta).
Però le questioni che pone attraverso la sua verve letteraria sono spinose: e se tutti possono capirle, purtroppo non tutti arriveranno ad intenderle e quindi men che mai ad accettarle.
In soldoni: l’opera non è, non deve più essere, una reliquia del passato da turibolare acriticamente, bensì manifestazione della contemporaneità: cioè a dire, un passato da non celebrare come tale ma da rapportare continuamente al presente. Cosa che compete agli interpreti (cantanti – e vale sempre l’aureo esempio della Callas, che nel riscoprire tecnica e dunque linguaggio antico ne proiettò il contenuto in una modernità tuttora attuale – direttori e, oggi necessariamente in prima linea, i registi) ma di conseguenza soprattutto ai direttori artistici chiamati a scritturarli. Non museo, in definitiva, bensì specchio del nostro sociale. Dunque, recuperare quella funzione anche politica che il teatro d’opera spontaneamente assumeva allorché stava in totale sintonia con la società cui si rivolgeva. E l’aveva perché teatro: che in quanto tale con conosce differenza sostanziale tra prosa e opera “lirica”, se non per il fatto che semmai la musica potenzia ulteriormente la parola; e che quindi baggianata più grande non potrebbe immaginarsi del famigerato “la regia – ovvero lo spettacolo – non deve dar fastidio alla musica”. Musica che perché mai, altrimenti, è stata scritta su di un testo?
L’opera, sostiene rettamente Mattioli rivolgendosi sottotraccia ai tanti direttori artistici che non mettono mai il naso fuori dai patri confini ma neppure si guardano un dvd, nonché alle “care salme” di certo pubblico (salme nient’affatto tali perché decrepite: i giovani, ahimè, sono spesso assai più zombi usciti da “Tombe degli avi loro”) ha svolto funzione esattamente sovrapponibile al teatro di parola nel fare politica discutendo delle grandi questioni che sempre si ripropongono e che quindi sempre ci riguardano. Poi il teatro di parola ha continuato, mentre l’opera in tale funzione è stata sostituita dal cinema allorché lo ha soppiantato come immaginario collettivo. Ridarle questa funzione sarebbe compito primario di chi organizza la vita dei teatri musicali accettando il fatto che i due termini sono del tutto paritetici. Castigat ridendo mores, dicevano gli antichi: Alberto fa spesso ridere coi suoi aneddoti autobiografici e con certe descrizioni di bassifondi, ma colpisce invariabilmente nel segno quando parla di teatro. Perché lo ama davvero, e quindi lodevolmente sprona affinché non sia l’amore per un museo (e nel museo, Alberto rettamente pone anche certe icone dello snobismo intellettuale più chic, quello che esalta sia i quizzari alla Castellucci sia i decoratori da qui all’eternità, tipo Wilson: noiosissima fuffa di non-teatro entrambi) bensì l’amore che si porta a qualcosa di vivo, anche – se non soprattutto – laddove taglia e fa sanguinare. È questo che fanno i veri classici del teatro: tali in quanto ne giustificano e ne esaltano l’esistenza. Bravo Alberto. Finché ci sarò, sarò sempre al tuo fianco. Dai, ti perdono anche la Grubi.
Elvio Giudici
Su “Classic Voice” di carta o in digitale c’è molto di più. Scoprilo tutti i mesi in edicola o su www.classicvoice.com/riviste.html



