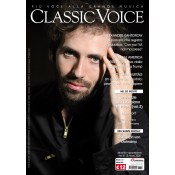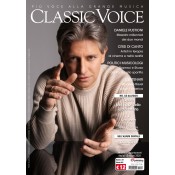Ci accoglie cortese nella sua casa vicino a piazza Napoli, a Milano. Libri dall’ordine recondito accompagnano il visitatore, foto degli affetti familiari, riconoscimenti di una vita di studi: a novant’anni la lucidità di Quirino Principe è inscalfibile, l’ironia, lo scatto nella conversazione sono intatti. Musicologo, poeta, germanista, traduttore: un crocevia di storie e mondi che ci ha permesso di scorgere in una lunga conversazione, aprendo un anfratto su una vita, iniziata a Gorizia martedì 19 novembre 1935, che si intreccia con la grande storia del secolo scorso.
Lo studio è ancora il centro delle sue giornate?
“È quasi una conquista. Ho avuto un periodo di stanchezza quando è morta mia moglie: a lei mi legava un amore unico. Ora la mattina è dedicata in gran parte a odiosi esercizi ginnico-terapeutici. Quindi, ricupero la notte. Io ormai non vado più a dormire. Ho sempre dormito molto poco, pochissimo”.
Oggi percorre nuove strade intellettuali o ricalca gli amori di una vita?
“Entrambe le cose. In parte ritorno nel pozzo del passato, dove si scoprono cose che non avevo ancora capito, certe poesie, certe musiche o certi aforismi filosofici che comprendo soltanto adesso”.
Ci mostra una serie di quadernetti in cui annota, con grafia minutissima e meticolosa versi italiani, provenzali, tedeschi, latini, ellenici, ispanici, russi, islandesi arcaici: “mi fanno compagnia durante la notte.” Con questa immagine si potrebbe sintetizzare la sua figura di studioso. C’è un exergo, in greco, il verso 757 (ψ’ν’ζ’) dell’Agamennone di Eschilo: ‘Diversamente da tutti gli altri, io penso con la mia testa” (dicha d’allon monòfron eimì)’. La gente si arrabbia a morte quando lo legge, e sbotta: ‘Chi crede di essere?!’. Seguo sempre un frammento di Eraclito, ‘ho indagato me stesso’. Difficile, vero? È quasi impossibile, poiché uno che indaghi su se stesso si ‘tuizza’, si estranea, diventa un tu, da io che era. Ne consegue la dedica…”.
A Lucifero…
“Avevo una nonna medium. Quando uno frequenta quel mondo si resta come risucchiati. Ha un fascino irresistibile. Non penso certo al demone da quattro soldi della finanza in giacca e cravatta, oppure a quello di certe logge massoniche, oramai veramente trash. Tutto ciò che ho fatto in vita mia aveva come finalità non chiedere, bensì conoscere, sapere. Lucifero è il portatore della luce che si ribella al buio. Ho dedicato un mio piccolo libro agli Yazidi, perseguitati dall’Isis, che vedono in Lucifero il redentore. Quella mia meditazione prendeva le mosse dall’ Inno ad Arimane di Leopardi. Penso che avremo una bella sorpresa dopo la nostra vita, se ci comportiamo bene, come nel romanzo di Chesterton, L’uomo che fu giovedì, in cui alla fine si scopre l’inanità della contraffazione e dell’inganno. È sempre un trauma, sfiorare i confini tra l’essere e il nulla. Il mondo può anche esplodere, se i due termini vengono a contatto. E questo a volte, purtroppo, è successo: esplori i capolavori dell’induismo, ti immergi nei testi sanscriti, e poi pensi alla perversione (anzi, al pervertimento) del significato originario della svastika. Quando la vedo nel film Parsifal di Syberberg ho lo stomaco in subbuglio”.
Possiamo sfatare il mito che lei sia poi così diabolico?
“Decidete voi. Quando ho iniziato la rubrica Gli imperdonabili sulla rivista ‘Studi Cattolici’ ho chiesto stupito perché lo chiedessero a me, non ‘credente’. ‘Perché sei cattivo’, mi risposero, e quasi mi fece piacere. Certo non mi manca la pietà nei confronti del dolore del prossimo, anzi, verso lacrime molto spesso. Ed è vero che ho sempre avuto rapporti ottimi e amichevoli coi miei studenti”.
Quando nasce il suo interesse per la poesia?
“Prestissimo. Avevo quattro anni. Ricordo che, prima ancora di andare a scuola, sentivo dire: ‘Ma guarda, questo bambino sa già scrivere. Tu che cosa scrivi?’. Rispondevo: ‘Scrivo poesie’. Naturalmente, non era vero. La poesia è un lavoro serio e delicatissimo, ed esige una lunga e faticosa maturazione tecnica. Ma da quella fase di vita, tra gli 8 e i 10 anni di età, mi sentii obbligato a renderle reale quel mio desiderio. Così il giorno dopo ho cominciato davvero a scriverne. Nel 1973 pubblicato il mio primo libro di poesia, Il libro dei cinque sentieri. Ho usato la forma metrica più difficile, la sestina arnaldesca, ABCDEF, FAEBDC, CFDABE, ecc… La poesia è anche un lavoro matematico”.
Lei è nato a Gorizia e lì ha trascorso l’infanzia…
“E di questo sono felice. Quelle coordinate geografiche mi hanno permesso di conoscere la lingua di Dante, e, nello stesso tempo, di nascere in una ‘terra di mezzo’, una città plurinazionale, come Trieste, città di mio zio. Nelle mie escursioni triestine frequentavo la Libreria Antiquaria di Umberto Saba. Durante la guerra, dopo il settembre 1943, fummo sfollati. Dovemmo abbandonare Gorizia, e trovammo rifugio in un paesino, Medea d’Isonzo. Dopo il processo a Ciano, Gorizia fu annessa al Terzo Reich. Al piano sotto al nostro alloggio giravano dei giovani soldati, peggio, delle giovani SS. Io giocavo da solo a Monopoli in un minuscolo giardino. Lanciavo i dadi, cambiavo sedia, immaginavo di essere altri tre giocatori, finché a un certo punto non chiesero rozzamente di aggiungersi al gioco anche i soldati delle SS. Ma erano molto incapaci, e così li rimproveravo continuamente. Mi ero portato da Gorizia alcuni libri, fra cui un vecchissimo vocabolario italiano-tedesco. Così, ho giocato con loro per qualche mese. Tornati a Gorizia, scampati a malapena alle stragi delle foibe, ricordo che assieme ad alcuni compagni di prima media andavamo fino a un ospedale dove erano acquartierati i soldati di Tito, armati fino ai denti. E li provocavamo. Siamo stati assolutamente incoscienti, perché questi avevano il dito sul grilletto”.
Quando ha lasciato Gorizia?
“Mi laureai a Padova con una tesi su Filone d’Alessandria. A Padova ero amicissimo di Pierluigi Petrobelli, ricordo il palazzo aristocratico di Prato della Valle, una cosa favolosa, la servitù in livrea e le donne anziane in crinolina. La sera veniva Claudio Scimone. Insieme organizzavamo concerti sinfonici, invitavamo Gulda, Badura Skoda, Cortot. Poi a Belluno, nel 1959-1960, prestai il servizio militare come ufficiale di artiglieria da montagna. E qui applicai il ‘Teorema Principe’. Si trattava di essere complice con il lato migliore dell’anima di quei soldati, di fingermi severissimo, una bestia sadica, coram populo. Era teatro! Si fingeva che qualcuno dei soldati avesse commesso un’azione riprovevole. E io, nelle camerate, inscenavo un processo durante l’ora del pranzo. Gli alpini, carissimi e bravi, si divertivano. Imparavano a fare teatro. Ma, finito il divertimento, la disciplina militare riprendeva il sopravvento. La domenica sera, quando la libera uscita era più prolungata, molto spesso i soldati semplici mi invitavano a cenare con loro, e vi assicuro che era uno spasso imperdibile. Per disposizione di natura militare-burocratica, quegli alpini erano per il 70 % veneti (non trentini né südtiroler, che andavano alla brigata Tridentina, e neppure giuliani o friulani, cha andavano alla Julia), e per il 30 % abruzzesi, romagnoli e toscani della Lunigiana. Vi lascio immaginare il miscuglio dialettale, a cena: esilarante soprattutto dopo qualche alzata di gomito con i vini di Valdobbiadene. Ogni volta, i soldati mi chiedevano di raccontare le trame dei drammi di Eschilo o di Shakespeare, o di declamare qualche canto dantesco. Quando mi accade di farlo ora, e mi accade spesso come sapete, penso sempre a quelle serate con gli alpini. Il colonnello che comandava il 6° Reggimento della brigata ‘Cadore’, dopo qualche perplessità, si complimentò con me per la lezione di drammaturgia, e anzi mi pregò di organizzare qualche proiezione di film all’aperto, la sera, prima della ‘ritirata’, per educare quei ragazzi a capire che il cinema è cultura. Ringrazio la memoria di quel colonnello con tutto cuore. Si può essere severi e intelligenti”.
 Infine, Milano.
Infine, Milano.
“Già! Vivo a Milano dal 1962. Mi fu affidata una supplenza nell’Istituto Tecnico ‘Cattaneo’. Non era l’ideale come tipo di scuola per me, ma vi trovai colleghi di prim’ordine e studenti simpaticissimi, culturalmente ingenui… e proprio questo mi insegnò quale fosse la grave e delicatissima responsabilità di un insegnante giovane e alle prime armi, come ero allora. Certo, il Liceo Classico, dove arrivai dopo avere vinto il concorso, era tutt’altra cosa: il mio paradiso. Ma l’entusiasmo fresco e vivo con cui le ragazze e i ragazzi del ‘Cattaneo’ mi avevano accolto, resta indimenticabile nel mio ricordo. Oltre all’insegnamento, che è stato il mio mestiere per tutta la vita, a Milano trovai subito da lavorare presso l’editore Garzanti. Livio Garzanti era un intelligente caratteriale, drammaticamente tormentato da un desiderio di perfezione e dall’urto contro la successiva inevitabile delusione. Coltivava e frantumava grande amore e poi odio mortale per i suoi dipendenti. Il giorno dopo la strage di Piazza Fontana entrò nello stanzone dove stavamo lavorando e si rivolse a me: ‘Dottor Principe, ho l’impressione che i responsabili siano i suoi amati altoatesini’. Allora la parte peggiore di me venne fuori: gli rovesciai contro una scrivania e me ne andai furioso. Appena ero arrivato a casa, e subito squillò il telefono. Temevo che fosse un infuriato Garzanti, che minacciasse di rovinarmi, e invece era la voce flautata di Alfredo Cattabiani che, saputo dell’incidente (ma come? con tanta velocità ?), mi invitava a lavorare per la neonata casa editrice Rusconi, che avrebbe pubblicato quasi tutti i miei libri fino a 1996, fra cui Mahler e Strauss”.
A Mahler e a Strauss ha dedicato due libri voluminosi.
“Ecco, Strauss è ancora poco esplorato. Penso al Krämerspiegel op. 66, un corpus poco noto di Lieder su sonetti tedeschi, scritti da un poeta di cabaret, Alfred Kerr. Strauss li mette in musica come se dovesse veramente scrivere per cabaret, cosa che gli “riesce” (!) fino a un certo punto, poiché è musica di altissima qualità, ironica e sublime. In uno di quei sonetti c’è la citazione del tema finale di Tod und Verklärung, un’autocitazione meravigliosa. Quel ciclo di Lieder è una enciclopedia in miniatura, geniale. Lo feci udire durante la mia relazione in un convegno alla Musikhochschule di Graz: nessuno di quei musicologi austriaci, tedeschi, slavi, inglesi, lo conosceva!”.
In diverse occasioni ha dichiarato che il grande amore musicale della sua vita è Robert Schumann.
“Prendete il Lied In der Nacht. È un’arcata che non si interrompe, cantata da una voce femminile cristallina, limpida, una linea melodica malleabile come argilla. Termina, non con una cadenza perfetta, ma con una cadenza plagale, sulla quarta. Allora interviene il tenore, un’ottava sotto, che la riprende e ripete tutto. È la semplicità che domina l’universo. È tutto ridotto a questo”.
E la vita musicale oggi, come la vede?
“Trovo molto riciclo. Il passato c’è, c’è sempre stato, e dev’essere metabolizzato. Anche Bach lavorava sul già fatto, come tutti. Però può esserci un sovrappiù oltre il quale l’edificio non sta più in piedi, l’immissione del già udito diventa così ingombrante che squarcia la struttura che l’artista si impone. Quando c’è un talento straordinariamente assimilativo è un pericolo, come Max Reger, una musicalità di incredibile ricchezza, ma ce n’era troppa. O Hindemith, il doctor subtilis della musica. Invece Strauss è riuscito ad avere un rapporto col passato molto più libero. A un certo punto ha deciso in modo anarchico di non creare un prima e un dopo dei valori, lo diceva un paio di anni poco prima della sua morte, quando disse chiaramente che a lui non interessa assolutamente nulla di somigliare al passato”.
E tra i compositori italiani del Novecento storico?
“A proposito di assimilatori, Alfredo Casella, è una musica ascoltata, digerita molto bene. Ma non aveva la personalità di Malipiero: Casella serviva la musica, Malipiero si serviva della musica, la faceva propria. Da riscoprire sarebbe anche Perosi, una sorta di Bruckner italiano.
Tra gli interpreti ce ne sono alcuni cui è particolarmente legato?
“Per quanto riguarda Mahler, mi colpì Klaus Tennstedt, il modo austero e ironico di interpretarlo. Tra i cantanti Gérard Souzay. Nessuno ha saputo interpretare Frauenliebe und Leben o Dichterliebe come lui, con un tono insinuante, non tedesco, francofono, lievissimamente androgino, che però era struggente.”
E i colleghi della musicologia e della critica musicale?
“Massimo Mila è venuto qui a cercarmi, dopo aver letto il libro su Mahler ne ha scritto una immensa recensione sulla ‘Stampa’ . Paolo Isotta era un amico, ne ho un caro ricordo, anche se non ero d’accordo con le sue idee politiche. Lo conobbi nel 1973. Aspettavo il treno alla stazione di Napoli, erano le undici e mezza di sera. Che cos’era la stazione di Napoli a quell’ora! Sbandati di ogni genere. Arriva una banda di scugnizzi, malvestiti, sporchi, che schiamazzavano, dicevano sconcezze, avranno avuto sedici anni. Ce n’era uno piccolo di struttura, un po’ strano, il più sguaiato di tutti, a un certo punto esclama: ‘Ich bin kein neapolitanischer General’, che è una citazione del Rosenkavalier. Era Paolo Isotta! Gli raccontai l’episodio, molti anni dopo”.
 Lei ha attraverso la seconda guerra mondiale, poi la Milano degli anni di piombo, la Milano del riflusso. Che rapporto ha avuto con la storia, con la politica?
Lei ha attraverso la seconda guerra mondiale, poi la Milano degli anni di piombo, la Milano del riflusso. Che rapporto ha avuto con la storia, con la politica?
“Un rapporto non soddisfacente, soltanto interiore, pensato, anche maledetto”.
Lei è stato un traduttore di grandi autori, da Tolkien a Jünger.
“C’è un profondo legame tra queste due figure. La geografia ideale del Signore degli Anelli è anche un po’ quella delle Scogliere di marmo di Jünger. Nel Signore degli Anelli tutto è fantasia, però è chiaro che il Bene è Nord-Ovest e il Male è Sud-Est. A mano a mano, che si va verso sud-est i nomi diventano prima fiabeschi e poi arabi, musulmani, che indicano il male proprio, Mordor. Così come nei Wilhelm Meisters Wanderjahre di Goethe i paesaggi non sono più realistici, non è più la Germania. Nella geografia di Jünger il Bene è l’esotico, noi invece siamo malvagi. In Jünger la realtà è mescolata con l’immaginario, si parla di cose reali, dell’Africa, dell’Asia, come nell’Operaio, dove a un certo punto si parla di un aviatore il quale va a bombardare Shanghai, vengono fuori questi frammenti di realtà. In Jünger ci sono cose terribili, atroci, che diventano gentili perché la descrizione le nobilita, per esempio la storia delle stragi compiute da pirati cristiani. C’è un capitolo nel Cuore avventuroso, meraviglioso, che è ‘La cava di ghiaia’ dove a un certo punto si mostra come tutte queste esperienze si incontrano in un punto all’infinito, e siamo trascinati a vedere queste cose piccolissime e minutissime”.
Quali sono i filosofi che più l’hanno formata?
“Gli antichi, nessuno li supera, nessuno. E nel Medioevo, mi piace moltissimo Sigieri di Brabante, messo tra gli eretici da Dante, ma in Paradiso. E poi amo molto Spinoza, naturalmente. Non amo particolarmente Hegel o Schelling. Cartesio mi ha appassionato il primo anno di università, poi me ne sono un po’ allontanato. E naturalmente Schopenhauer e Nietzsche. Tra i viventi stimo Giorgio Agamben e Vito Mancuso. Nella mia concezione dell’universo ogni oggetto è animato, come nel pensiero di Giordano Bruno. A tal proposito ho composto una poesia a partire da un ritrovamento archeologico, il sarcofago etrusco di una bambina sepolta insieme alla sua bambola. Nel mio componimento la bambola parla alla bambina.
E fra i poeti è noto il suo amore per Borges…
“Nella poesia Scacchiera, Borges si domanda chi c’è dietro a Dio? In fondo, se noi lo smettiamo di pensare ad una piramide con une misure rettilinee, e incominciamo a pensare secondo la curvatura che è palese nel cosmo, vediamo che il problema si risolve facilmente. E poi andando avanti in cerchio siamo a diciamo 180 gradi di distanza perfettamente simmetrici perché il tutto è così. Che cos’è la piramide? È qualcosa che ha il di sopra che culmina con un enorme piazzale. Sì, per noi uomini è qualcosa di piccolissimo ma per i microbi è come una piazza d’armi e quindi tutto ricomincia da lì, no? Si va sempre verso l’analisi di misure sempre più piccole. Se io volessi andare al Polo Nord, quale parte dei miei piedi è sul Polo Nord? È un punto geometrico senza estensioni allora non c’è nulla che si trovi esattamente al Polo Nord. Non c’è più bisogno di domandarsi che cosa c’è sopra questa cosa perché c’è un’altra cosa sopra la quale ci sarà un’altra cosa. Come nel Novellino, quando i dotti della Sorbona si interrogano su chi sia sopra Dio: ‘il cappello’ risponde il giullare. Tutti ridono, ma il rettore della Sorbona, a malincuore osserva: “Resta il fatto che non sappiamo rispondere…”.
Marco Brighenti e Valentina Trovato
Il Teatro alla Scala festeggia Quirino Principe il 21 novembre al ridotto dei palchi Toscanini alle ore 17. Nell’occasione viene presentato il suo nuovo libro “Un wagneriano alla Scala” a cura di Raffaele Mellace (Libreria Musicale Italiana). Saranno presenti, oltre all’autore e al curatore, Andrea Estero e Marcello Nardis
Su “Classic Voice” di carta o in digitale c’è molto di più. Scoprilo tutti i mesi in edicola o su www.classicvoice.com/riviste.html